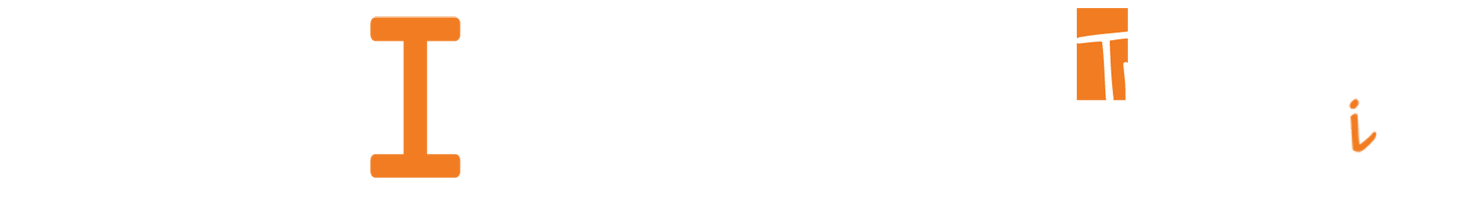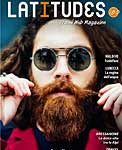di Elia Rossi
Prima di atterrare a Lampedusa, bisogna planare sul mare, schizzando di poco sopra la sua superficie blu. Finisce che il punto in cui l’aereo si posa sulla terra coincide col punto in cui la terra inizia. Una sporgenza di calcare e dolomite in mezzo al mar Mediterraneo. Un pezzo di placca africana in territorio italiano. Per essere più precisi: il centro abitato più meridionale d’Italia (Lampedusa è in provincia di Agrigento, ma rimane più a sud di Algeri e Tunisi). Quando si esce dall’aeroporto, ci si trova davanti a un magnifico panorama magrebino, il cui giallo però ricorda i limoni di Sicilia: le sue granite, i suoi scrittori, i suoi tempi riflessivi. Per le strade, quasi, non c’è segnaletica, eppure tutto procede senza urti né frenesie, come se i pochi automobilisti si osservassero i volti per capire insieme come gestire i rari, e piccoli, incroci.
È difficile mettere a fuoco i lampedusani. L’isola ha vissuto per molto tempo nell’isolamento politico. Quando Garibaldi consegnò l’Italia unita al Re, questo ci mise dieci anni prima di scoprire che disponeva anche di quel territorio e solo nel 1878 lo riconobbe come comune italiano. Ma questo non aveva impedito a Lampedusa di essere uno scorcio sui dolori e le gioie europei. Quando il veliero Giuseppe Secondo fu colpito dal colera che imperversava in Turchia ed Europa e ricevette, a La Valletta, la «fede sporca» che lo costringeva alla «navigazione errante», cercò di attraccare a Lampedusa, che dovette allontanarlo con la minaccia di affondamento. Pochi anni dopo, un pescatore scoprì al largo di Lampedusa il primo banco di spugne e l’isola fu invasa da avventurieri italiani, greci, turchi e tunisini. All’isolamento politico di Lampedusa, non è corrisposto un isolamento culturale, e così i suoi abitanti sembrano dei siciliani più europei dell’Europa stessa.

Oggi è come se tra i suoi vicoli assolati, pieni di banchi di spugne colorate, capperi e lenticchie secche, ci fosse l’Europa classica, quella dei greci, dei romani, degli arabi e degli spagnoli. Nella contrada di Cavallo Bianco si erge la Porta d’Europa: una scultura di Paladino. La sua ceramica è stata cotta a mille gradi, per riflettere, nel Mediterraneo circostante, i raggi del sole e della luna. Vuole essere un faro umanistico, che rinfranchi lo sguardo di chi l’Europa la sogna dal mare africano, ma è ingiusto isolare il suo ruolo all’esperienza della migrazione odierna. Lampedusa è stata la porta d’Europa da sempre. Per usare un simbolo tra i tanti: nel 1943, su un’intuizione di Churchill, Pantelleria e Lampedusa furono il primo pezzo di suolo italiano su cui misero piede gli alleati nelle loro operazioni contro il nazifascismo. E oggi andrebbe considerata non solo porta d’Europa, ma centro.
A Lampedusa si muovono gli impulsi di una piccola città mondiale. Ci sono festival cinematografici internazionali, come Vento del Nord, o quello curato dall’associazione Askavusa, che nelle sere estive proietta storie e documentari in una piazza che sembra fatta di creta. Nonostante i 6000 abitanti, l’isola dispone di un’associazione come “Archivio Storico” che, tra le altre attività, ha riproposto una ricerca di Annamaria Brignone. È in quelle pagine sugli “Usi, credenze e superstizioni intorno al ciclo della vita umana” che si mettono un po’ più a fuoco i lampedusani o, quantomeno, il loro ricchissimo folclore. Si leggono decine di “scongiuri”: filastrocche che scacciavano malattie e paure, ma che potevano essere memorizzate solo la notte di Natale. Si legge che quando un bambino dormiva di giorno e vegliava di notte aveva la “cuntraria” e bisognava lavare i suoi pannolini nel mare. Si legge che quando una coppia si fidanzava, la lana dei loro materassi veniva immersa nel Mediterraneo e fatta asciugare sugli scogli, intorno a una festa domenicale.

Una sorta di Erasmus spontaneo e discreto porta ogni anno volontari di tutta la comunità europea nel Centro di Recupero Tartarughe Marine. Sono molti gli eventi toccanti che ruotano intorno alle caretta caretta dell’Isola. Come la cura delle uova deposte sulla spiaggia di fronte all’Isola dei Conigli. Se percorrendo la mulattiera che scende alla spiaggia, e trovandovi di fronte a quel panorama cristallino, azzurro e immerso nello zillare delle cavallette, aveste la sensazione di aver già visto quel luogo, è tutto regolare. Saranno i lampedusani a spiegarvelo, con un tono tra il risentito e l’orgoglioso. Spesso, per rendere più attraenti i cataloghi di alcune isole caraibiche, i fotografi italiani vengono qui. Risparmiano sul viaggio e hanno la stessa luce e gli stessi colori, producendo lo stesso sfarfallio negli occhi dei viaggiatori. ? er
Foto Elia Rossi e Web Riproduzione riservata © Latitudeslife.com