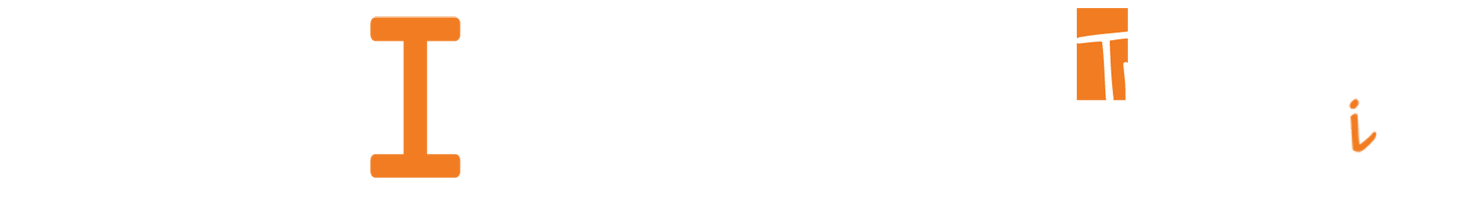Viaggiare in epoche lontane, incontro a popoli e civiltà che sono parte della storia e dell’evoluzione dell’uomo. L’archeologia è viva, e in tante zone del mondo assume significati che vanno oltre la testimonianza. Opere e manufatti possono essere considerati simboli blasfemi e impuri da abbattere, oppure utilizzati per rivendicare diritti, identità, supremazie. Questi temi e molto altro vengono trattati a Paestum, dove da oltre vent’anni si tiene la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Un momento unico nel suo genere, luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale ed al patrimonio; occasione di incontro per gli addetti ai lavori, per gli operatori turistici e culturali, per i viaggiatori. Una vetrina ampia e diversificata dell’offerta turistica legata ai siti archeologici e beni culturali, in particolare, ma non solo, del bacino Mediterraneo.

Nell’ultima edizione della Borsa, dal 15 al 18 Novembre 2018, è stato anche celebrato il ventennale dell’iscrizione di Paestum nelle liste del patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco. Delle tante meraviglie inserite in questo elenco, Paestum incarna oggi al meglio lo spirito dei principi dettati dall’Unesco: estetica, unicità, autenticità. E in più è il luogo dove l’archeologia si dimostra fattore di dialogo interculturale, d’integrazione sociale e di sviluppo economico. Ogni anno la Borsa promuove la cooperazione tra i popoli attraverso la partecipazione e lo scambio di esperienze.
Accoglie e sostiene con orgoglio i siti oggetto di attacchi e gli archeologi che si sono battuti in loro difesa, come dimostra il gemellaggio tra Paestum e Palmira, e il premio intitolato a Khaled al-Asaad, che ne fu l’ultimo eroico direttore. Ed è qui che possono risuonare parole importanti come quelle pronunciate da Moncef Ben Moussa, direttore del Museo del Bardo di Tunisi all’epoca dell’attentato del marzo 2015 (attuale direttore per lo Sviluppo dei Musei): “L’archeologia ci insegna che il Mediterraneo è sempre stato luogo di scambi, di conoscenza, di integrazione fra i popoli, al di là delle contese. E l’estremismo nasce dove c’è un vuoto. La nostra risposta è stata quella di costruire luoghi di dialogo, aprendo due nuovi musei nella zona più difficile, all’interno della Tunisia.”

L’occasione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico con tutta la sua ricchezza di contenuti e presenze nazionali e internazionali, dà modo a chi già non la conoscesse di visitare una delle aree archeologiche più importanti al mondo e fra le più interessanti della Magna Grecia.
La città antica era circondata da una cinta muraria quasi totalmente conservata di circa 4,70 Km. Costruita con grandi blocchi squadrati, era intervallata da 28 torri e possedeva quattro porte principali corrispondenti ai punti cardinali. La parte visitabile di Paestum si estende per 110 ettari, su un terreno pianeggiante mantenuto a prato naturale, canneti, pini marittimi. La città venne fondata da coloni greci provenienti da Sibari verso il 600 a.C. nella parte più orientale del golfo di Salerno a 10 chilometri dalla foce del fiume Sele. Inizialmente venne costruito il porto marittimo e fluviale e presso di esso sorse il Tempio di Era Argiva, ora distrutto. Una fondazione che si perde nel mito. Di certo i colonizzatori giunsero su navi. Per questo la città dell’entroterra fu chiamata Poseidonia, in onore di Poseidone, dio del mare, e nel tempo divenne una vera e propria metropoli dell’antichità. Ai greci si deve l’edificazione nei canoni dell’ordine dorico dei monumentali templi – i più grandi d’Italia – che dominano e nobilitano con la loro bellezza il paesaggio circostante.
Conosciuto come Basilica, il tempio di Hera, protettrice degli Achei e sposa di Zeus, iniziato intorno al 560 a.C. è il più antico dei tre grandi edifici. E anche il più integro di un periodo fondamentale per l’evoluzione dell’architettura greca. Il tempio non si attiene alle regole classiche dell’ellenismo, e per questo c’è voluto tempo prima che si confermasse la sua funzione di luogo di culto. Ma è bene fissare subito un concetto che ci tornerà comodo più oltre nell’inquadramento di questa città perduta. Nella società della Magna Grecia le celebrazioni religiose avevano fondamentalmente una funzione sociale e politica, e i riti si tenevano su altari posti all’esterno del tempio, che custodiva la statua della divinità, ma era inaccessibile al popolo. Solo il sacerdote e le vestali potevano entrare.

Noi invece oggi, grazie alle scelte illuminate e coraggiose del giovane direttore dell’area archeologica Gabriel Zuchtriegel, possiamo entrare nel tempio attraverso un percorso sperimentale che ha anche abbattuto le barriere architettoniche. L’effetto è pura emozione, che contagia tutti. Persino le vocianti scolaresche tra un selfie e una foto ricordo non riescono a staccare gli occhi dalle possenti colonne incombenti e svettanti verso il cielo. Un analogo percorso si trova nel Tempio di Nettuno, il più grande e meglio conservato di Paestum.
Realizzato verso la metà del V sec. a.C., rappresenta la declinazione classica dell’architettura templare greca. Il nome è stato attribuito nel Settecento, quando si iniziarono a studiare gli edifici, pensando fosse stato dedicato a Poseidone-Nettuno, la divinità dalla quale la città greca prese il nome. Ci sono però altre ipotesi. La più accreditata ritiene il tempio costruito in onore di Zeus, suffragata dal ritrovamento nei pressi di una statua in terra cotta che lo rappresenta. Si può ammirare invece per ora solo dall’esterno il terzo tempio, quello posto a nord in posizione dominante. Era dedicato ad Atena, la dea dell’artigianato e della guerra, e venne edificato attorno al 500 a.C..
Sulla spianata molte altre vestigia, risalenti all’epoca romana. Fra le più notevoli, il foro e l’anfiteatro. Prima dei romani per due secoli circa Poesidonia era stata dominata dai lucani, che l’avevano conquistata gradualmente, infiltrandosi fra i greci, e cambiandole il nome in Paistom. La loro presenza è testimoniata soprattutto dalle tombe affrescate, e dai ricchi corredi funerari. I romani occuparono la città nel 273 a.C. che così divenne la fedele Paestum, vicina a Roma anche nei momenti più drammatici della sua storia.

I romani trasformarono in parte il disegno della città greca secondo i propri canoni urbanistici, ma come i loro predecessori non toccarono i templi e lasciarono intatto il cenotafio, la tomba (vuota) dedicata al fondatore, forse un certo Megyllos. Anche i romani la consideravano inviolabile, una sorta di sepolcro sacro posto a protezione della città. Gli scavi del 1954 hanno riportato alla luce splendidi vasi in bronzo contenenti un impasto di cereali e miele, conservati nel bellissimo Museo Archeologico Nazionale di Paestum, in prossimità dell’area archeologica.
Il museo contiene diverse sezioni che consentono al visitatore di ripercorrere la storia della città greca, lucana e romana. Oggi è arricchito da percorsi multimediali molto apprezzati dai giovani che fanno vivere nella realtà virtuale edifici e ambienti com’erano nelle diverse epoche. Riguardo alle collezioni possiede pezzi di valore storico e artistico inestimabile provenienti dall’area archeologica e da scavi e siti in zone limitrofe. E’ difficile rimanere indifferenti di fronte a tanta bellezza. Soprattutto guardando la raccolta di pitture funerarie delle tombe, una pratica diffusa nel IV secolo a.C., durante il dominio lucano. Scene per lo più figurate per i sepolcri maschili, con guerrieri bardati di elmo e corazza, e decorate con vari motivi ornamentali per quelli femminili.

Ma l’autentica star del Museo è la cosiddetta Tomba del Tuffatore, scoperta nel 1968, antecedente all’epoca lucana e singolare esempio per dimensioni e soggetto di pittura di età greca della Magna Grecia (480/70 a.C.). La figura del giovane sospeso nel vuoto, quasi stesse volando, nell’atto di raggiungere lo specchio d’acqua sottostante, incanta chiunque l’osservi. Sul significato profondo di questa immagine il dibattito è ancora aperto. Perché se davvero come pare rappresenta il passaggio dalla vita alla morte, il guizzo giocondo e consapevole del tuffatore mal si sposa con l’idea dell’aldilà degli antichi greci del V secolo a.C.: un luogo di tenebra tutt’altro che lieto. In più non ci sono elementi nell’affresco utili a decifrarlo. La scena è spoglia ed essenziale, senza nessun riferimento a divinità o figure mitologiche. E si trova all’interno sulla lastra di copertura della tomba, per “guardare” il defunto.
Secondo alcune teorie l’immagine allude al transito verso un mondo di conoscenza, che va oltre le pratiche dei simposi raffigurati invece compiutamente nelle lastre laterali: l’abbandono al vino, all’eros, all’arte, ovvero musica, canto o poesia. L’estasi ricercata nel mondo terreno è solo un trailer sbiadito di quanto c’è dopo questa vita. Chissà se è davvero questo il significato originario? Poco importa, quel che conta è il suo magnetismo, la seduzione e gli interrogativi profondi che riesce a suscitare.

Un viaggio a Paestum significa anche scoprire il litorale e l’interno, e sperimentare le produzioni alimentari della Piana del Sele, una delle più fertili d’Italia. Orticoltura, oleicoltura, viticoltura e allevamento di bufale danno vita ad una cucina tipica strepitosa, riconosciuto pilastro della dieta mediterranea.
Dove mangiare

Ristoranti e trattorie di ottimo livello, non mancano. Ed è curatissima, nonché basata sul territorio, anche la cucina dei grandi hotel indicati più oltre.
A colpo sicuro nella tradizione: Agriturismo Tenuta Vannulo. Via Galileo Galilei, 101 – Paestum
Ambiente accogliente e cucina curata al ristorante dell’Hotel Villa Rita

Dove dormire
Lusso e servizio impeccabile al Savoy Hotel. Via Poseidonia 291 – Paestum.
Di gran classe anche l’adiacente Esplanade Hotel. Via Poseidonia – Paestum.
Il citato Villa Rita, silenzioso, confortevole a due passi dall’area archeologica. Via Nettuno 9 – Paestum.
Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico
Testo e foto Gianfranco Podestà|Riproduzione riservata Latitudeslife.com