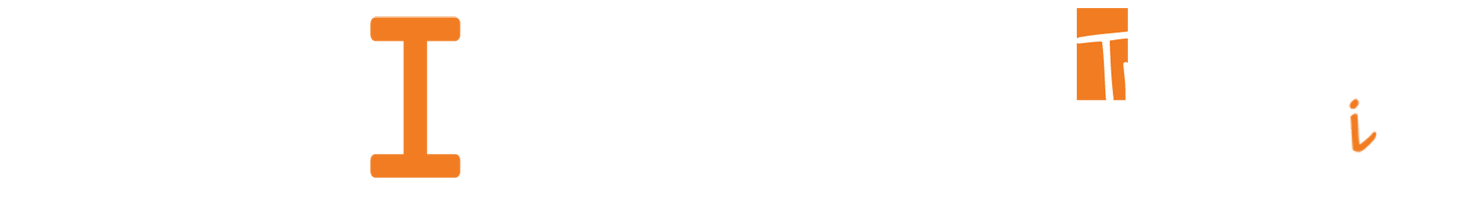La strada era un insieme caotico di vite appese alle volontà delle acque scure che limitavano la città, qualche chilometro più in là. Mezzi di trasporto di ogni sorta spingevano i pedoni fuori dalle proprie disinibite traiettorie, a rimarcare una sorta di divisione in caste in quell’asciutto “codice stradale” popolare, tramandato sottilmente di progenie in progenie. Ai miei occhi da principiante di Varanasi, questo metamondo veicolare di viaggiatori quotidiani, affastellati con la naturalezza che l’istinto di sopravvivenza ti dota in questi casi, era apparso una montagna troppo alta da scalare, una moltitudine di vite così strettamente intrecciata da farmi sentire fuori posto e svuotato d’ogni intenzione, crudelmente colpevole di non aver saputo immaginarmi al caldo della mia casa questo vivere impossibile e banalmente reale.
Arrivato al mio hotel “vista Gange”, mi accolse una nitida ed alta nuvola di polvere, dentro la quale l’autista del mio taxi mi fece scendere, forse per concedermi una zona cuscinetto prima dell’apparizione della mistica Varanasi dei ghat e dei fedeli tra le sue acque. Mi infilai nell’albergo e poi nella mia stanzuccia all’ultimo piano: il Gange si intravedeva appena. Decisi allora di preparare uno zainetto e visitare subito le rive del fiume. Nella mia mente le immagini delle tante foto e documentari visti su Varanasi intasarono tutto lo spazio disponibile: dentro di me una curiosità vivida si fece largo in un momento, assumendo la forma di una lancia di luce puntata dritta sul mio ipotalamo. Finalmente potevo vedere dal vivo e toccare, impastandoci tutte e due le mani, l’atmosfera spirituale per eccellenza: sembrava quasi che nell’aria di Varanasi corresse perenne la musica ipnotica di un sitar da rituale.
Il lungo fiume fluiva tra cemento e rivoli davanti ai miei occhi, orlato da un via vai modesto di gente. Insieme ai commercianti, ai pochi turisti ed agli abitanti, figure vestite di poco stazionavano ai piedi dei Ghat, imponenti costruzioni induiste che stendevano la propria lingua di scale fino al Gange. Appollaiati sulle prospicienze del fiume stavano alcuni in chiara meditazione. Lontano, le pire funerarie comunicavano fra loro con i segnali del fumo dei corpi bruciati di indù deceduti, mentre restituivano le loro ceneri alla Madre. Una testa glabra sbucò dalle acque del fiume e sentii una sorta di sgomento inaspettato: sapevo infatti che quel liquido che scorreva maestoso davanti a me era un ammasso chimico di inquinamento, il riversamento dell’intera fognatura della città, un ricettacolo di virus e batteri come pochi al mondo. Da un punto di vista fisiologico, era un’acqua morta. Non immaginavo, però, che la mia anima occidentale e pragmatica prendesse così il sopravvento sulla spiritualità del luogo. Come mi disse l’indomani una guida del posto “noi qua dimentichiamo una volta al giorno quello che ci dicono i dottori: ci bagniamo con l’acqua sacra del Gange venendo qui, oppure con delle taniche che teniamo in casa. Poi torniamo a vivere la vita di tutti i giorni, sapendo quello che rischiamo”.
Mi immersi tra le pieghe delle ritualità, tra i gesti lenti e misurati della gente, tra le nebbie che si disperdevano fino a diluirsi nella riva opposta, deserta. Una musica attirò la mia attenzione e mi diressi verso un ghat. Entrato, le note rendevano densa ed umida l’aria, danze sudate ed estatiche irruppero nel presente dominandolo in toto. Una donna seduta su un muretto vicino all’entrata mi squadrò, incorniciata da un velo colorato e solcata da rughe scure ed henné, porgendomi la mano. Non capii le sue intenzioni fino a quando non intravidi il brillare delle monete tra le sue dita chiuse. Arpionai degli spiccioli in tasca e li porsi alla donna: con un rapido gesto ritrasse la mano, dopo aver preso le monete. Fece uscire lesta l’altro braccio, che era rimasto nascosto dietro la sua schiena, mettendo in luce una piccola tazza con del liquido: ne versò il contenuto sulla mia mano. Non ebbi tempo né capacità di fare niente. Capii che era una sorta di benedizione e purificazione con l’acqua del Gange: un lieve bruciore psicosomatico mi solcò la mano e deglutii sperando nel meglio. Mi inoltrai un poco nel ghat, ma fui quasi subito preso a mal parole (a giudicare dall’intonazione) ed invitato ad uscire con gesti eloquenti: ce l’avevano con le mie scarpe, che avevo dimenticato di lasciar fuori, insieme alle altre. Mortificato per aver stupidamente oltraggiato il tempio, me ne uscii subito. Dando un’ultima occhiata, vidi i danzatori che suonavano a ritmo sempre più incalzante, ritirati nella loro dimensione spirituale, totalmente assenti da qualunque scambio con gli altri fedeli lì presenti.